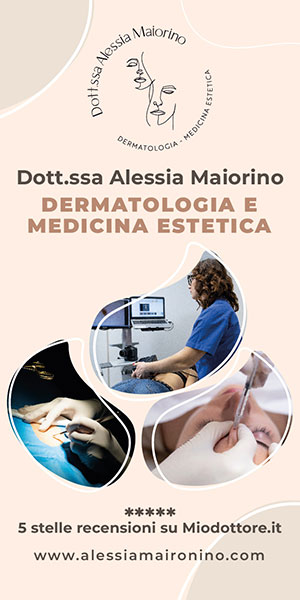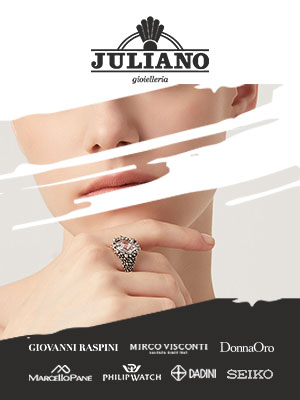Note sul libro di Luigi Leuzzi: “La Terra dei Tristi: il Cilento. La ragione antropologica del sospetto” (Centro di Promozione Culturale per il Cilento, 2012), che il prossimo 29 aprile 2023, alle ore 17:00, sarà al centro del dibattito nell’ambito degli “Incontri Empatici”, organizzati dal Centro Contemporaneo delle Arti a Roccadaspide.
Verso la fine dell’ottocento, alcune indagini nel territorio cilentano rilevavano la precarietà delle condizioni di vita e la miseria palpabile soprattutto nelle genti più umili.
Due erano stati gli avvenimenti che nel corso del secolo avevano caratterizzato il territorio ed avevano visto tra i protagonisti quelle persone scontente e disilluse dai governanti, i Borbone. I moti del 1828 e del 1848, che erano liberali e rivendicativi di diritti, coinvolsero anche gli umili e diedero impulso alla speranza di cambiare qualcosa, non tanto in termini politici quanto piuttosto per il miglioramento delle condizioni di vita.
Ci furono sommovimenti e scintille che partirono dalle idee illuministiche e dal periodo murattiano. Essi interessavano però in prevalenza i ceti medio-alti della borghesia; poi ci fu il 1820, definito il focolaio di tutte le rivolte; le retate e gli arresti degli anni successivi (nel Cilento 1833 e 1837); la spedizione di Pisacane nel 1857. Infine, successivamente, il brigantaggio segnò in maniera drammatica il post-Unità d’Italia. Tutto ciò accadde tra rivoltosi illuminati, idee liberali e repubblicane e popolazione che viveva nell’indigenza.
I Borbone definirono per questa ragione il territorio: “Terra dei Tristi”.
Quando ci si rapporta al termine “triste/tristo”, non troviamo una definizione univoca. Alcuni pensano ad uno stato d’animo individuale, di origine psicologica, che significa anche lugubre e rancoroso; altri alla natura malvagia e perversa di chi delinque; altri ancora ai sovversivi e ai briganti. In quest’ultimo caso, poi c’è da definire i briganti, coloro che sono stati attivi nel territorio meridionale dopo l’Unità d’Italia ed in forma estensiva anche coloro che hanno inteso ribellarsi nel periodo borbonico. Infatti, quei tristi, hanno riguardato un periodo storico abbastanza ampio, fino agli ultimi decenni dell’ottocento, offrendo una connotazione legata ad idee politiche di rottura dell’ordine costituito.
Di tutte queste cose si occupa il volume di Luigi Leuzzi, analizzando le prese di posizione di molti studiosi, antitetiche e che oscillano tra gli umili che lottano contro i soprusi (Chieffallo), ai sovversivi che sposano la causa liberale (Rossi). Poi ci sono: Galanti, che sottolinea la ferocia, lo spirito di vendetta; Rizzi, che rileva la crudeltà, l’abitudine ad uccidere; Gatti, che si riferisce alla bellicosità e ad uno spirito antireligioso. Inoltre, una sorta di ambivalenza tra comandare con alterigia e servire vilmente, come sostengono i Borbone, che rilevano l’inclinazione alla sedizione, alla rapina, ai reati di sangue. Questa concezione li identifica con indemoniati che attentano alla vita civile.
I Tristi comunque sono contro chi governa, vivono una condizione psicologica e sociale che sfocia nella protesta e si dedicano ad azioni violente. La confusione con i briganti è dunque evidente, soprattutto perché di brigantaggio in termini estensivi si intende una condizione che va dall’esigenza di un cambiamento politico (qui alcuni ne lodano perfino le azioni) ad attività che nella fase finale diventa violenza tout-court, al soldo di qualche potente oppure per arricchimento e gestione di un potere personale.
Durante tutto l’ottocento, ci sono state profonde contraddizioni e lacerazioni nel tessuto sociale: da un lato il declino della nobiltà terriera e dall’altro la borghesia che si consolida. Mentre tutto ciò accade, contadini e bracciali non riuscirono ad accedere alla governance e ad affermare le proprie esigenze e i bisogni sociali ed economici. Le misere condizioni portarono molti di questi soggetti alla macchia ed accrebbero le fila dei briganti: il servizio di leva fu un altro elemento di disillusione verso il cambiamento post-unitario, causando una ribellione contro la società che li emarginava.
Leuzzi è convinto che ai tristi sono accomunati sia gli umili cilentani che i turbolenti briganti, e rileva le caratteristiche antropologiche dei cilentani. Seguendo questo ragionamento, si nota una commistione di tratti: chi subisce ma anche chi si ribella, chi è dotato di connotazioni positive e chi si distingue per il delinquere. Dunque, il versante antropologico del termine è quello centrale nelle argomentazioni dell’autore.
Prima di trattare l’aspetto innovativo della sua analisi, voglio dare qualche altro contributo sul termine “tristo” che ha caratterizzato la società cilentana. Un tempo le donne cilentane, riferendosi ad un proprio figlio, dicevano: “Com’è tristo!”. Si affermava l’idea di un bambino cattivo, nel senso di vivace, discolo, ma anche intrattabile e rissoso. Ad ogni modo, quell’espressione non era del tutto negativa, anzi lasciava intendere quasi un senso di ammirazione per il coraggio, la capacità di affrontare la vita, lo stare tra gli altri e il sapersi affermare. Almeno quello sembrava l’intento, cogliendo quelle voci e quelle espressioni. Del resto, c’era bisogno di qualcuno che fosse in grado di difendere la famiglia, l’onore e la possibilità di vincere contro la miseria dell’esistenza.
Ecco, credo che “tristo” significhi proprio tutto ciò. Non è dunque solo il brigante, o almeno non solo in accezione esclusiva. Nella comunità c’è chi è più “tristo” di altri e compie soprusi: il collettivo e la generalizzazione non possono per questo essere accomunati in quella tipologia, non possono costituire una caratteristica propria del territorio.
Luigi Leuzzi delinea questa natura, trattata con grande esaustività. Centrale è il mito di Dioniso, ovvero la natura mitologica del “tristo”. Il punto di partenza è la vita silvestre e rurale, alternativa a quella urbana. Il dio Pan o Fauno riconduce a saturnali e baccanali, con particolare attenzione alla natura mercuriale di trasformazione e sovvertimento dell’ordine costituito. C’è un’inclinazione atavica e un istinto di sopravvivenza, la ribellione ai criteri imposti dal padrone, l’insofferenza rispetto ad un sistema oppressivo. Nell’elemento dionisiaco è riscontrabile il rapporto stretto con la natura, dove c’è un’area impervia e un’uniformità tra il mondo antropico del brigante e l’istinto animalesco.
Dioniso incarna il pensiero emozionale contrapposto a quello razionale (Apollo). È il principio arboreo-vegetazionale che accompagna coloro che si danno alla macchia (natura). Qui c’è poi anche il sovvertimento di ruoli, dove le brigantesse (Chieffallo) di fatto diventano maschi, vestendo abiti maschili. Diventano atroci, come le sacerdotesse di Dioniso che erano invasate, con il volto mascherato (Menadi). Il dio invece era circondato da Satiri, le forze fecondatrici della natura, lascivi, amanti del vino e delle danze.
Assimilati alla fame predatoria dei briganti, ci sono quei tristi che sequestravano e violavano, rapivano e stupravano. È l’animale/uomo/Dioniso che uccide ed è ucciso. Tutti questi culti riconducono alla condizione di ebbrezza e irrazionalità.
L’autore trova in ciò la ragione antropologica del sospetto, che è caratterizzata dalla frattura profonda tra umili e dominanti, ed al tempo stesso l’assenza di noità, dove l’alter ego è alieno e non socius; si sviluppano relazioni autoreferenziali e solipsismo. Le comunità sono frammentate e si averte la perdita di appartenenza, con mancanza di iniziative progettuali, rassegnazione e fatalismo, conseguente alla condizione del mancato sviluppo economico.
Qui però Leuzzi porta la sua analisi all’attualità, figlia comunque di quei tempi passati.