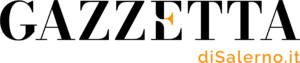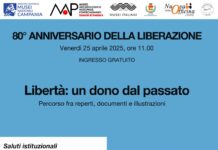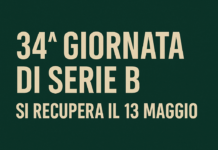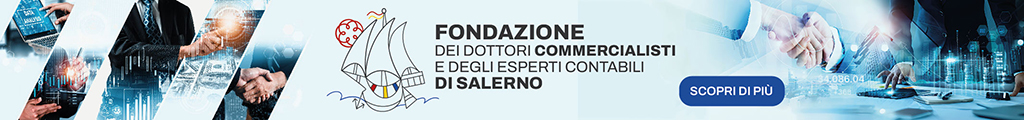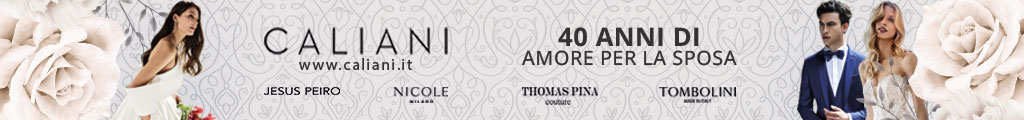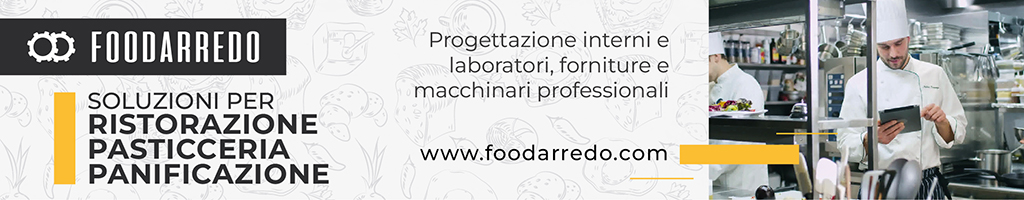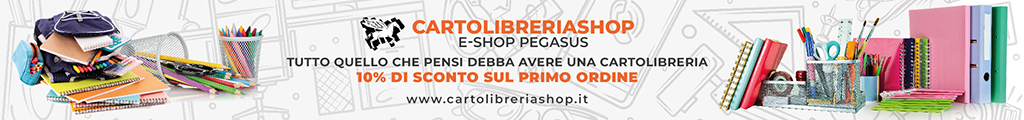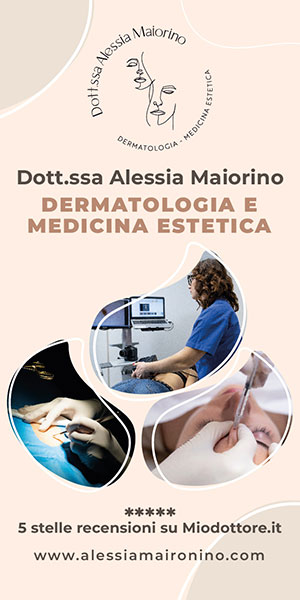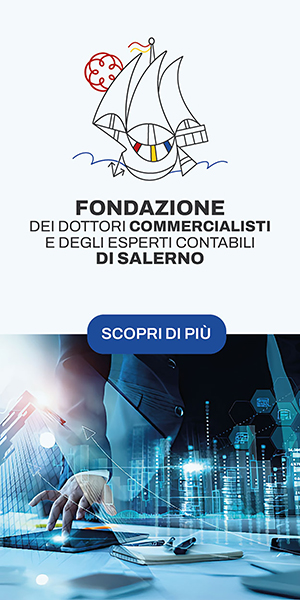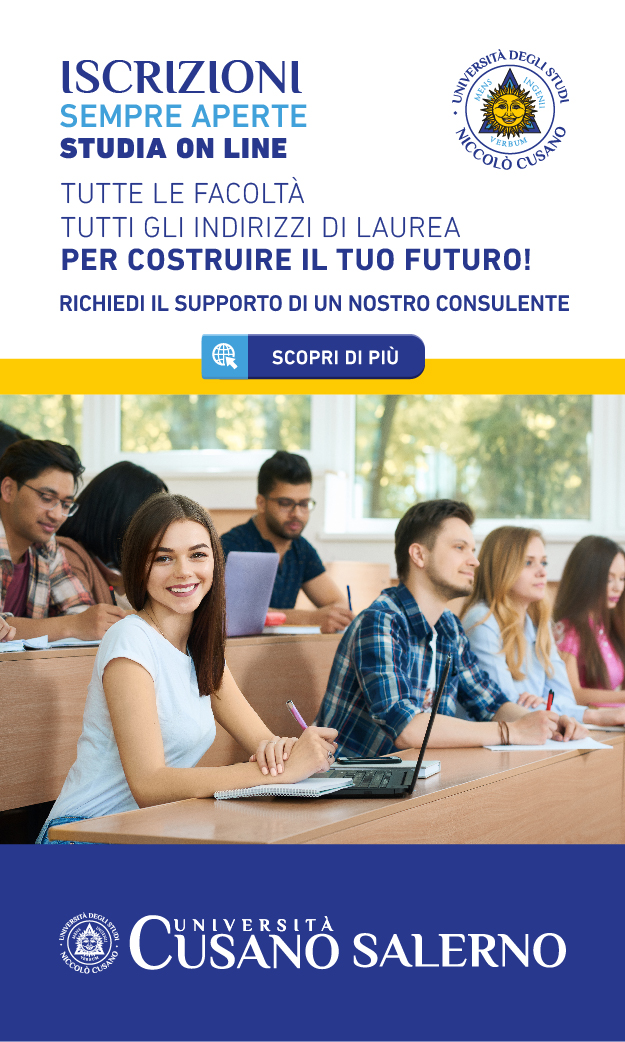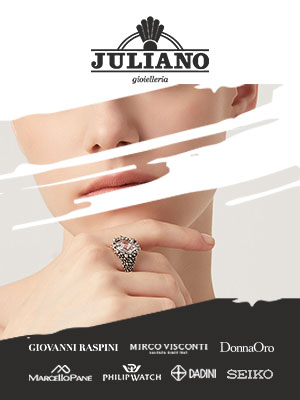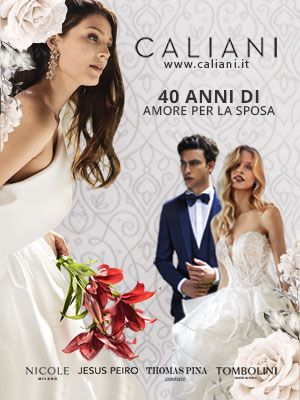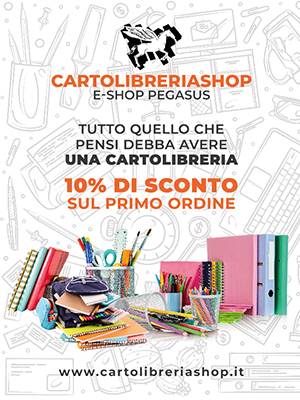Il “Carcalenzio di Sant’Antonio” è il rituale del fuoco in occasione della festa del Santo Patrono di Montecorvino Pugliano. L’iniziativa ha come momento centrale l’accensione dei fuochi, un’espressiva forma rituale, come segno di purificazione.
In tutto il Meridione, l’uso popolare di bruciare grosse cataste di tronchi d’albero ammucchiati nelle piazzette è il modo di vivere una cultura che, rifacendosi alle origini, ripropone le vecchie abitudini e consuetudini. Il “fuoco dei ceppi di legno”, a seconda della località, assume nomi diversi: “‘a fòcara”, “u’ fòcaro”, “u’ ceppone”, “u’ falò” e il “Carcalenzio” a Gallara.
Il fuoco è inteso come risveglio della natura, la propiziazione e l’evocazione della luce che sconfigge le tenebre e domina sulla notte, la paura, il freddo e, rassicurando gli uomini, dà origine alla ritualità che allontana le potenze malefiche.
Nelle società arcaiche esposte al rischio esistenziale, quando erano tutti inermi nel fronteggiare la natura, quando per impetrare la grazia del raccolto, delle piogge, si ricorreva a qualche santo, quando l’eccesso o la mancanza di precipitazioni erano ugualmente pregiudizievoli per una “buona annata”, ebbene allora si ricorreva a pratiche che servivano a rasserenare l’esistenza comunitaria. Oggi, quelle pratiche sono simbolicamente rappresentate dalle feste religiose che si svolgono nei vari paesi.
La religione ha costituito l’elemento principale di coesione comunitaria, dove prevaleva il volere di Dio, il dovere dell’uomo, l’organizzazione sociale e il tipo di relazioni sociali.
Uno degli aspetti più aggreganti è rappresentato dalla trasmissione dei valori e delle tradizioni, che non avveniva secondo codici e saperi formali ma attraverso l’esempio dei padri, le storie e le leggende narrate, la vita vissuta ed imitata.
Le tradizioni erano in genere acquisite tramite racconti che riguardavano eventi oscuri e terribili, quando il male sembrava prevalere, e situazioni liete, nel caso di intervento di una figura protettrice rappresentata da un Santo o dalla Madonna.
In genere il Santo che si festeggia in ogni comunità, il Santo Patrono, è raffigurato con aria mite e ascetica. Si dice: “è bello, bravo, simpatico”, ma lo si insulta anche se non fa la grazia, il miracolo.
È impotante anche per coloro che non credono perché si tratta di un personaggio di “genius loci”, il simbolo identitario di una comunità.
Entra in gioco nella precarietà dell’esistenza per trovare il senso di esorcizzarla. Se la comunità ha un problema trova nel Santo la speranza: il sensus fidei fidelium, sostengono i teologi. Il Santo sa cogliere nella manifestazione del prodigio (per la Chiesa ufficiale questo termine è collocato al posto del miracolo) il significato profondo della fede: qui il dolore della vita è colorato di speranza, una speranza oltre ogni speranza.
Si mescolano fede e superstizione, sacro e profano, in un sentimento sincero proprio della pietà popolare. Un sentimento genuino di un popolo che ascolta il proprio cuore. È il trait-d’union tra superstizione e fede, che si fonde nella devozione che lega la gente al suo Santo Patrono.
Il rapporto devozionale è fatto di promesse, fatti, voti reciproci, in cui il Santo è parte costitutiva della cultura, religione, pensiero, immaginazione e di tutte le manifestazioni tra il Santo e la gente: si consolida un rapporto di stima, un patto sacro, moralmente ed emotivamente manifestato; un coinvolgimento della popolazione tra speranza e timori per il futuro ignoto. I segni sono le espressioni tangibili, il legame tra corporeo e essenza dell’essere vivente, il soffio vitale che anima l’uomo. Esiste un legame collettivo, un rapporto confidenzaile e consolidato che travalica i confini della spiritualità, attribuendo al Santo la protezione salvifica dell’intera comunità.
La festa è strettamente legata alla comunità e tende a mantenere uniti i suoi membri. In passato, quando i legami erano molto forti e stretti, la tradizione considerava: calendario, abitudine, necessità di rottura del quotidiano, bisogno di communitas, ovvero tutti quegli elementi che spingono gli uomini ad aggregarsi e a vivere l’evento festivo.
Una definizione che mi va di condividere è quella di Paolo Apolito quando sostiene che “la festa è legata al vissuto emotivo dei partecipanti: è tutto ciò che sta intorno al complesso rituale”.
Apolito fa una distinzione tra festa e rito, dove quest’ultimo è “un insieme formalizzato di azioni cerimoniali” che vengono compiute dalla popolazione; la festa, al contrario, rappresenta qualcosa che si stabilisce intorno al complesso rituale, è una sorta di cornice del vissuto. Il rito è particolarmente forte nel caso della religione, non lascia spazio al vissuto dei partecipanti, ad azioni che esulano da un percorso formalizzato: infatti, i rituali sono azioni abitudinarie inserite nelle categorie di tempo e luogo.
La ritualità è stata sempre la principale caratteristica delle feste che si sono diffuse e consolidate nella tradizione e nella cultura popolare. I rituali rappresentano “una connessione tra passato, presente e futuro” e rendono possibile “continuità e cambiamento”.
Pur nella consapevolezza che le società umane non sono immodificabili, chiuse, ma adottano le novità che giungono dall’esterno, metabolizzandole, rielaborandole e facendole proprie, occorre tuttavia considerare l’importanza dei rituali tradizionali nella conservazione e nella trasmissione della cultura, riaffermando le credenze e gli ideali collettivi fondamentali della comunità.
Diventa interessante occuparsi della descrizione di una festa, attraverso il simbolismo della tradizione: una processione attraversava il paese e si recava nelle campagne circostanti; lo spostamento aveva una relazione con l’organizzazione dello spazio proprio della società, basata sull’opposizione tra spazio umanizzato e spazio naturale.
Oggi paiono riprendere vigore le manifestazioni culturali e folkloristiche. Il problema pare essere quello di trovare feste con un largo consenso e forme rituali che ancora resistono ma di cui occorre meglio ricercare una aggregazione, un senso comune, un’appartenenza.
Gli elementi della festa sono costituiti da: tempo, luogo, significati, espressioni che accompagnano l’evento, forme rituali e sociali.
Sul versante sociale la manifestazione festiva si caratterizza per organizzazione e partecipazione all’evento, elementi storici ed economici.
L’antropologo Lello Mazzacane ha compiuto studi sulle feste religiose nel Mezzogiorno: “Pellegrinaggi, Sacre Rappresentazioni e Feste Patronali”.
Per spiegare tali tipologie di feste ci si può avvalere di aspetti: penitenziali, rituali e magico-religiosi. Esiste anche un elemento socio-economico, ma esso viene collocato entro la sfera dei rapporti comunitari.
Per evidenziare lo schema di Mazzacane, ci si riferisce a:
a) modalità del comportamento (azione culturalmente orientata dagli individui);
b) funzioni cui la festa assolve (risposta istituzionalmente organizzata rispetto ad esigenze culturali socialmente condivise);
c) comportamenti e funzioni (relative ad alcune forme del rituale);
d) rapporti sociali presenti in quel tipo di feste (rapporti economici, scambi e relazioni tra classi dominanti e dominate).
Le feste religiose fanno ricorso a cerimonie che permettono alla popolazione di vivere non solo il momento ludico e festivo, ma anche la rappresentazione rituale del sacro, la condivisione e la partecipazione alla grandezza del Santo, della divinità a cui si fa richiesta della grazia e si fa il voto.
Ad ogni modo, esiste un controllo istituzionale dell’autorità religiosa attraverso una serie di prescrizioni. D. Hervieu-Léger descrivendo ad esempio la processione sostiene che il praticante debba adeguarsi ad alcune regole: una pratica obbligatoria; una pratica regolata dall’istituzione; una pratica fissa; una pratica comunitaria; una pratica territoriale (stabile); una pratica ripetuta.
Se le feste sono spiegate come momento rituale per rinsaldare l’unità sociale all’interno della comunità, esse sono espressione di quei momenti di effervescenza collettiva attraverso comportamenti e atteggiamenti che trasportano in un mondo speciale, del tutto diverso da quello in cui ordinariamente vive, in un ambiente completamente popolato di forze di eccezionale intensità, che lo pervadono e lo trasformano. La festa permette “la ri-costruzione della comunità nei momenti di aggregazione”, in cui la coesione si mantiene viva grazie anche alle risorse che ruotano attorno al momento festa. Esso può essere inteso come un “istituto sociale” caratterizzato da una data di nascita e dalla sua forma più o meno consolidata nel tempo. Dunque si tratta di un organismo vivo che pur legato ai suoi rituali, si alimenta e trae la sua ragione d’essere nel cambiamento: è un patrimonio del passato che si rinnova continuamente nel presente.
Le manifestazioni folcloristiche possono essere ricondotte entro due essenziali classificazioni: quelle legate alle forme espressive della spiritualità e quelle create e programmate entro confini organizzativi ben strutturati.
Nel primo caso, rientrano le manifestazioni religiose che conservano simboli e riti di antiche origini, che sono calendarizzate e servono a festeggiare il Santo Patrono o altre espressioni di fede che si presentano.
La seconda classificazione è quella delle feste organizzate che riproducono forme espressive del passato ma guardano alla programmazione per la perfetta riuscita della rappresentazione. In questo caso la manifestazione, pur ospitando personaggi legati alle tradizioni ed ai simboli del passato, non sono legate allo spontaneismo, alla rottura di schemi prestabiliti, ai momenti non ritualizzati.
Oggi si può parlare di superamento di queste classificazioni, attraverso la costruzione di alcuni indicatori soggettivi e qualitativi. Essi hanno permesso di osservare: le modalità organizzative e l’impegno dei partecipanti; il rapporto tra tradizione e cambiamento; la ricaduta in termini economici e di sviluppo grazie soprattutto alla presenza di pubblico.
Si è cercato di rilevare come gli individui siano portati ad aggregarsi per condividere le occasioni festive e, di conseguenza, come le iniziative devono essere organizzate, considerando le esigenze della popolazione.
Vivere l’evento festivo diventa condividere i momenti relazionali, e di conseguenza trovare gli stimoli, rappresentati dalle manifestazioni che il territorio propone.
Nel caso delle feste religiose, come quella celebrata in onore di Sant’Antonio con il rituale del Carcalenzio, il rito è molto seguito e partecipato: si tratta di proporre la devozione di una comunità che si stringe intorno alle sue tradizioni.
In conclusione, i significati e i simboli sottesi a questa festa sono importanti per sottolineare la stretta relazione che ancora caratterizza il rapporto tra territorio e religione, tra natura e spirito, e tra tutti quegli elementi che hanno e continuano ancora a segnare profondamente la vita dell’uomo e il suo forte bisogno di socialità e spiritualità.